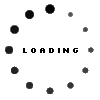INCONTRO
“Un incontro di due:
occhi negli occhi, volto nel volto.
E quando tu sarai vicino:
io coglierò i tuoi occhi,
e li metterò al posto dei miei,
e tu prenderai i miei occhi
e li metterai al posto dei tuoi.
Così io guarderò te con i tuoi occhi
e tu guarderai me con i miei.
Così persino la cosa comune impone il silenzio
e il nostro incontro rimane la meta della libertà:
il luogo indefinito, in un tempo indefinito,
la parola indefinita per l’uomo indefinito.”
( J.L. Moreno 1985: 7 ).
Psicodramma, Sociodramma e Sociometria debbono la loro origine e la loro prima diffusione nel mondo alla persona di J.L. Moreno , psichiatra di origine romena, che svolse la sua pratica e ricerca professionale prima nella Vienna degli anni ‘20 e successivamente negli Stati Uniti d’America.
Riferimenti storici: j.l. Moreno
J.L.Moreno nacque a Bucarest nel 1889 ma trascorse l’infanzia e la prima giovinezza a Vienna dove ebbe la sua formazione culturale e professionale, studiando dapprima filosofia e laureandosi successivamente in medicina. Uomo portato a condividere il clima ed i fermenti culturali della Vienna degli anni ’20, fondò insieme a Martin Buber e ad altri intellettuali viennesi la rivista “Daimon” ed iniziò le prime esperienze di avanguardia teatrale alternandole al lavoro clinico come medico psichiatra. Nel 1925 si trasferì negli Stati Uniti a causa del clima politico ed autoritario che si andava profilando in Europa e che non facilitava lo sviluppo delle sue idee e dei suoi progetti. Lavorò dapprima con lo Psicodramma con i bambini del Plymouth Institute of Brooklyn e con gli adulti alla clinica psichiatrica dell’ospedale Monte Sinai di New York. Continuava nel frattempo il lavoro di integrazione di teatro e Psicodramma all’Improptu Group Theatre presso la Carnegie Hall (New York).
Nel 1936 aprì una clinica privata a Beacon (vicino a New York) dove realizzò il primo teatro di Psicodramma. Gradualmente Beacon divenne un centro di formazione per Direttori di Psicodramma e punto di incontro e formazione per clinici provenienti da tutto il mondo. Oltre a “Il teatro della spontaneità” (scritto negli anni di Vienna), pubblicò “Psycodrama I”, “Psychodrama II”, “Psychodrama III” (opere sistematiche sullo Psycodramma) e “Who shall survive?”, opera nella quale sistematizza le ricerche e le esperienze sociometriche, sociodrammatiche e terapeutiche svolte presso il riformatorio femminile di Hudson. Fu il fondatore della prima organizzazione internazionale di terapia di gruppo (lo I.A.G.P. = International Association of Group Psychotherapy), che attualmente riunisce terapeuti e conduttori di gruppo dei più diversi orientamenti teorici. Nel maggio 1974 moriva a Beacon.
Teatro della spontaneità e giornale vivente
I presupposti della nascita di psicodramma e sociodramma vanno ricercati nell’intersezione dei due orientamenti culturali e ideali compresenti in Moreno:
? l’interesse per la sperimentazione teatrale ad orientamento sociale;
? l’interesse per la sofferenza psichica.
Negli anni venti Moreno creò un gruppo teatrale che realizzava rappresentazioni con il pubblico, senza utilizzare copioni, sceneggiature, ma creando al momento l’azione drammatica a partire da tematiche sociali rilevanti o da temi suggeriti dal pubblico. Nasceva il teatro della spontaneità, matrice di fertili intuizioni creative sul ruolo e sul funzionamento della dinamica psichica, sulla funzione della spontaneità e della creatività, sul gruppo e su tutti quei concetti sui quali si edificherà lo psicodramma.
” Il giornale vivente ” è il prototipo del teatro della spontaneità. Gli attori con l’ausilio del pubblico rendevano concreti, percepibili e ”drammatici” alcuni fatti e situazioni di cronaca, oggetto d’interesse e dibattito per il pubblico.
Il teatro della spontaneità si orientò successivamente alla rappresentazione ed alla elaborazione, mediante il coinvolgimento del pubblico, di problemi e situazioni esistenziali emergenti “in situ” dai partecipanti. Gli attori si trasformavano progressivamente da “dramatis personae” in IO ausiliari, specchi stimolanti per i drammi reali della vita di tutti i giorni delle persone. Il pubblico da una posizione passiva si trasformava in attore partecipe, assumendo il ruolo di contenitore o di cassa di risonanza, come nel coro della tragedia greca.
E’ in questo ambito di fermento creativo che Moreno scopre la valenza terapeutica dei metodi di azione . E’ noto a tal riguardo il caso di Barbara, che consentì a Moreno di sviluppare la metodica dello psicodramma terapeutico. Barbara, giovane attrice del “Teatro della spontaneità”, si era da poco sposata con uno scrittore, George. Ella ricopriva sempre il ruolo di fanciulle gentili ed ingenue. Un giorno il marito George, in preda a disperazione, si confidò con Moreno rilevandogli che a casa la moglie si mostrava una donna intrattabile, dal linguaggio volgare, che addirittura lo picchiava quando cercava di fare l’amore con lei.
Qualche giorno dopo il giornale riporto in cronaca nera la notizia dell’assassinio di una prostituta per mano del suo protettore. Moreno ebbe un’intuizione: convincere Barbara a rappresentare la parte della prostituta. Così fece: ed ella ricoprì quel ruolo con tale forza, stimolando l’attore che faceva da protettore ad una risposta così frenetica che al culmine della scena del delitto il pubblico si alzò in piedi gridando: “basta!”.
A casa, dopo lo spettacolo, temporaneamente liberata della sua carica aggressiva, Barbara fu insolitamente tenera con George. Moreno continuò a farle rappresentare caratteri violenti, ed ella diventava sempre più trattabile quando si allontanava dal teatro. Un giorno Moreno invitò George sul palcoscenico accanto a Barbara, per duplicare gli episodi della loro vita privata. “Alcuni mesi più tardi” – egli racconta – “essi si sedevano con me in teatro, pieni di gratitudine. Avevano riscoperto se stessi e il loro rapporto”.
L’episodio di Barbara aveva concretizzato un elemento che rimane fondamentale nello psicodramma, un elemento già noto agli antichi drammaturghi greci: la “catarsi”.
Lo psicodramma
Psicodramma deriva dai termini greci “PSYCHE'” (psiche o anima) e ”DRAMA” (azione). E’ quindi quel metodo che consente di esplorare il mondo psichico attraverso l’azione. Fu negli Stati Uniti, a contatto con le problematiche della malattia mentale, che lo psicodramma si strutturò come metodo terapeutico-curativo. Inizialmente le sessioni si realizzavano con uno o pochi pazienti ed uno staff di IO ausiliari professionisti che avevano la funzione di esternare il mondo reale e fantasmatico dei pazienti.
Successivamente lo psicodramma si strutturò sempre più (fino ad assumere le caratteristiche attuali) come terapia di gruppo, ove la funzione di IO ausiliario viene assunta dai pazienti stessi, rendendo non più necessaria la presenza di IO ausiliari professionisti.
Lo psicodramma manteneva tuttavia collegamenti con ambiti extra-terapeutici, sia nelle sessioni aperte (incontri di psicodramma aperti al pubblico, ove era il pubblico stesso ad entrare in azione) sia nello psicodramma addestrativo (rivolto ad allievi e professionisti), che possedeva somiglianze con le metodologie attuali di supervisione con modalità psicodrammatiche.
Il sociodramma
Il sociodramma nasce dall’esigenza di confrontarsi con quelle contraddizioni sociali e culturali che rimandano contemporaneamente sia alla dimensione psicologica intrapsichica che a quella social-culturale.
Negli Stati Uniti, in particolare, era cruciale la problematica razziale, con le sue implicazioni di pregiudizio, paura, difesa e discriminazione sociale. Il sociodramma, come strumento di intervento sui grandi gruppi, si prestava ad elaborare costruttivamente le problematiche cruciali di una comunità (sesso, conflitto generazionale o razziale, pregiudizio verso determinate categorie quali carcerati, malati di mente, ecc.). A differenza dello psicodramma, il sociodramma non si interessa tanto al mondo interno del singolo, quanto a quelle dimensioni che appartengono e trapassano trasversalmente gli individui di una determinata categoria o realtà sociale. Detto in altre parole, il sociodramma si occupa di ruoli sociali e delle loro rappresentazioni interne e culturalizzate.
L’addestramento al ruolo
L’interesse per l’addestramento e la formazione è dato in Moreno dalla prima esperienza del Teatro della spontaneità. Si trattava in questo contesto di addestrare l’attore alla spontaneità e alla creatività, alla capacità di inventare il ruolo e di sapere fronteggiare e concretizzare in modo spontaneo le imprevedibili situazioni proposte dal pubblico.
La preoccupazione principale era il superamento delle “CRISTALLIZZAZIONI CULTURALI” (stereotipi e rigidità di ruolo) per giungere alla condizione di spontaneità, premessa alla possibilità di creatività nella realizzazione del ruolo. Questo lavoro di preparazione dell’attore richiama alcune delle tecniche tuttora utilizzate nell’addestramento e nella formazione (le simulazioni e le attività di warming-up, o riscaldamento).
Fu però soprattutto nel lavoro con la comunità femminile di Hudson che Moreno utilizzò le tecniche di azione con finalità di addestramento professionale e di elaborazione delle dinamiche di gruppo delle ragazze ospiti. Queste ragazze adolescenti provenivano da esperienze di criminalità e prostituzione e si poneva alla struttura che le ospitava il compito di reinserirle nella società, fornendo loro competenze sociali e professionali, oltre che una possibilità di riequilibrio psico-affettivo. Moreno lavorò con loro con i metodi del Role-playing, dell’anticipazione delle situazioni future e anche con interventi di psico-terapia di gruppo.
L’accento era posto sull’intreccio di acquisizione di specifiche competenze di ruolo lavorativo e di formazione di una personalità capace di interazione positiva e di spontaneità.
“Un adattamento ottimale a più ambienti richiede una personalità adattabile e spontanea. […] Il nostro metodo ha parecchi vantaggi su quello consistente nel formare gli individui ad un buon adattamento sociale mediante la diretta esperienza di situazioni di vita reale. […] Prima di tutto, la serietà delle situazioni reali impedisce all’individuo di prendere coscienza dei suoi errori : la sua ansia gli farà ripetere gli stessi errori quando si ritroverà di fronte a situazioni analoghe. […] In secondo luogo le situazioni reali creano in numerosi individui una specie di inerzia affettiva dovuta al fatto che, essendo riusciti positivamente in un certo ruolo, si comportano come se non venisse loro richiesto qualcosa di più . […] Inoltre, se le situazioni reali formano un individuo in modo che possa adattarsi perfettamente ad un certo ruolo, […] tendono ad escludere dal suo orizzonte altri orizzonti. […] Per tutto ciò l’apprendimento della spontaneità, in quanto METODO DI SVILUPPO, è superiore all’apprendimento che può venire offerto dalla vita. […] Il problema dell’apprendimento non sta più nel suscitare o nel mantenere delle abitudini, bensì nel formare la spontaneità, nello sviluppare negli uomini l’abitudine a tale spontaneità ” (Moreno, 1980: 165)
La sociometria
L’interesse per la misurazione e la rilevazione qualitativa e quantitativa delle relazioni nei piccoli e nei grandi gruppi ha sempre contraddistinto il lavoro di Moreno. Tuttavia è solo nel 1934, con la pubblicazione di “Who Shall Survive?”, che Moreno sistematizza quella che lui definisce sociometria.
La sociometria moreniana (o misurazione dei rapporti sociali) ha avuto un’ampia diffusione in ambito educativo e nella ricerca sociale. Anche in questo caso, come per numerose tecniche dello psicodramma, e avvenuto una specie di “saccheggio” di fertili intuizioni operative, riutilizzate in campo sociale, educativo e terapeutico da operatori che facevano riferimento a modelli teorici anche lontani dallo psicodramma.
La sociometria, intesa come mera tecnica di rilevazione o “diagnosi statica” (che produce grafici, sociogrammi e dati numerici), è molto distante dal significato operativo e trasformativo che Moreno aveva inteso dare. Per Moreno, infatti, la sociometria è uno strumento volto alla comprensione degli spostamenti relazionali all’interno di un gruppo, in funzione di una trasformazione evolutiva delle possibilità del gruppo stesso e delle persone. La vera sociometria moreniana è la “sociometria d’azione”, fotografia immediata e mutevole delle relazioni gruppali, con l’intento di agire subito in modo spontaneo e creativo sui nodi critici di tali relazioni.
E’ tale l’uso che Moreno fece della sociometria nella comunità di Hudson sopracitata. In questa realtà Moreno utilizzò il sociogramma come strumento per modificare e migliorare le relazioni fra le giovani ospiti di Hudson: le ragazze grazie all’indagine sociometrica avevano la possibilità di strutturare la vita quotidiana in funzione combinata dei loro bisogni affettivi e degli obiettivi futuri di reinserimento sociale.
ELEMENTI CARDINE DELLA TEORIA MORENIANA
Teoria del ruolo
Per capire a fondo il significato di “RUOLO” nella teoria moreniana occorre subito differenziare tale concetto dalle due accezioni di ruolo più diffuse:
? Ruolo in senso sociologico;
? Ruolo in senso teatrale.
Il ruolo sociologico fa riferimento soprattutto alle concrete realizzazioni sociali dei ruoli, rimandando a categorie culturali e sociali di rappresentazione della vita sociale. Un ruolo sociale (es.: vigile, medico) ha determinati confini prestabiliti, compiti, sanzioni e gerarchie di status ecc., che prescindono dall’individuo e dalla persona che deve assumere questo ruolo.
Il ruolo in senso teatrale si riferisce immediatamente al concetto di “MASCHERA”, finzione ed illusione. In questo caso si parla di recitare un ruolo o una parte, non di essere quella parte.
In entrambi i casi, sia che si parli di ruolo sociale “appiccicato” ad un individuo, sia che si parli di recitare un ruolo, vi è una separazione tra la soggettività e l’apparenza .
La specificità dell’apporto moreniano alla teoria del ruolo riguarda da un lato l’estensione del concetto di ruolo a tutti gli ambiti del comportamento umano, dall’altro il collegamento ad aspetti corporei, soggettivo-intrapsichici e sociali.
Moreno definisce il ruolo come:
“ La forma operativa che l’individuo assume nel momento specifico in cui reagisce ad una situazione specifica nella quale sono coinvolte altre persone od oggetti ” (Moreno, op. cit., pag. 158) .
Per capire come i ruoli siano interconnessi con l’individuo e non siano soltanto una sovrapposizione esterna, bisogna pensare alla funzione strutturante del ruolo per la personalità. E’ l’IO che emerge dai ruoli e non viceversa. L’esperienza diretta di molteplici ruoli da parte del bambino appena nato struttura una percezione corporea, emotiva e successivamente rappresentativa del suo sé e della sua collocazione nel mondo. Il lattante sperimenta gradualmente vari ruoli, di succhiatore, di dormitore, di cucciolo coccolato, accettato o rifiutato, ecc. e sarà la confluenza e l’unificazione corporeo-emotiva e rappresentativa di tali esperienze a fare emergere l’IO.
In tal senso è evidente come l’IO si sviluppa mediante e grazie ad una notevole penetrazione del sociale nell’individuale. Moreno individua quattro categorie di ruoli che si sovrappongono successivamente nello sviluppo dell’essere umano:
- ruoli psicosomatici (corporei), sono i primi ad emergere nello sviluppo del bambino. Sono tutti quei ruoli che riguardano le funzioni corporee (mangiare, dormire, sensazioni propriocettive, ecc.);
- ruoli fantasmatici o psicodrammatici. Iniziano a comparire prestissimo quando si abbozza la vita rappresentativa nel bambino. Sono quei ruoli che riguardano il mondo interno della persona e racchiudono la peculiarità fantastica ed emotiva di ogni essere umano (il ruolo di “bambino ubbidiente” o cattivo, di sognatore, magico, ruoli fantastici di fate e di streghe, fantasmi divoratori e immagini oniriche…);
- ruoli sociali . Esperienzialmente compaiono alla nascita (infatti un lattante vive già il ruolo sociale di figlio anche se non ne è cosciente), però la loro strutturazione interna rappresentativa (intesa come capacità di percepire gli individui come appartenenti a categorie sociali) data all’inizio della scuola elementare. Sono quei ruoli che appartengono alla società nella quale l’individuo vive e si sviluppa. Essi vengono codificati culturalmente e socialmente (ruoli di figlio, genitore, maschio o femmina, lavorativo ecc…).
N.B.: Per chiarire ulteriormente: se parliamo DEL genitore (il suo ruolo, i suoi compiti) ci riferiamo ad un ruolo sociale; se parliamo di UN genitore specifico, per come è vissuto, concettualizzato ed interpretato da un singolo individuo, ci riferiamo ad un ruolo psicodrammatico.
- ruoli valoriali (o trascendentali). Hanno la loro comparsa ed esplosione “emotiva” nell’adolescenza (tempo elettivo di sogni, illusioni, progetti e “filosofia di vita”). I ruoli valoriali concernano il senso e la finalità dell’operato dell’uomo: sono il contenitore che orienta la vita attraverso gerarchie di valori, utopie e progettualità esistenziali.
N.B.: I ruoli valoriali sono connessi fortemente sia ai ruoli psicodrammatici che ai ruoli sociali: infatti da un lato rappresentano la specificità esistenziale dell’individuo (i suoi valori), dall’altro sono anche il prodotto di rappresentazioni sociali (ad esempio il ruolo di educatore porta con sé una serie di valenze valoriali quali: l’aiutare gli altri e riparare ciò che non è giusto, ecc…).
I l fattore S-C (spontaneità-creatività)
I riferimenti filosofici dello psicodramma rimandano ad una concezione dell’uomo come essere capace di liberarsi dai limiti impostigli dalla sua condizione, e capace di liberare spontaneità e creatività.
Da questo punto di vista l’orientamento psicodrammatico può essere inquadrato come finalistico, espansivo, volto alla valorizzazione delle risorse dell’essere umano; l’orientamento psicoanalitico, al contrario, può essere visto come deterministico e centrato maggiormente sui limiti ed i segni lasciati nella persona dalla sua storia.
L’ipotesi teorica ed immediatamente operativa dello psicodramma postula la compresenza nell’esperienza in ogni individuo (e nei gruppi) di due dimensioni intimamente collegate: la spontaneità e la creatività. Ogni essere è dotato della possibilità di essere spontaneo e di un certo grado di creatività.
Per evitare fraintendimenti è necessario chiarire che cosa intende Moreno per spontaneità. Essa non è ciò che il linguaggio comune definisce: un comportamento privo di regole che fa uscire in modo incontrollato emozioni, pensieri o azioni indipendentemente dalle esigenze della. La spontaneità è piuttosto una condizione che può essere creata in ogni individuo, uno stato interno che può essere prodotto e che costituisce la base per l’espletarsi della creatività.
La spontaneità è pertanto un catalizzatore per la creatività e l’una senza l’altra portano conseguenze negative e non produttive. Moreno definisce due estremi a tal riguardo:
? il deficiente spontaneo , colui che in uno stato perenne di “spontaneità”, ma privo di risorse creative, fornisce in continuazione risposte inadeguate all’ambiente e dettate solo da bisogni e stati interni;
? il creatore disarmato , colui che, ricco di potenzialità creative, non riuscendo a creare in sé uno stato di spontaneità, resta paralizzato e non riesce ad esternare le potenzialità creative (al pari della parabola evangelica dei talenti, nella quale il servitore con tanti talenti non necessariamente li mette a frutto).
E’ importante sottolineare che la spontaneità può essere educata, sviluppata e ricreata mediante un processo di riscaldamento.
La metodologia psicodrammatica parte dal presupposto che la spontaneità può manifestarsi in determinate situazioni (esempio uso del corpo, umorismo, situazioni di intimità e di contatto con l’altro, ecc.) e in tutte le persone, anche quelle più limitate o malate. E’ per questo che metodologicamente la fase di riscaldamento (o warming-up) è particolarmente curata nei gruppi di psicodramma.
Da questo punto di vista quello che il formatore è chiamato a fare, in psicoterapia, in formazione e nelle situazioni di apprendimento, non è altro che una risposta creativa scaturita dopo una fase di incubazione, in un momento di adeguata spontaneità.
Un buon equilibrio del fattore S-C porta da un lato alla capacità di dare risposte adeguate ad una situazione nuova e imprevista, e dall’altro di saper dare una risposta nuova e creativa ad una situazione vecchia e cristallizzata.
Tele e incontro
Sviluppando operativamente gli apporti filosofici di MAX BUBER, Moreno individua nella possibilità di INCONTRO (inteso come capacità dell’essere umano di entrare in relazione emotiva con i suoi simili, in modo autentico e non distorto) la chiave di lettura della salute mentale e dell’equilibrio della personalità. La capacità d’incontro presuppone che siano attivi i processi di tele .
TELE significa “a distanza”, ed indica la capacità presente in ogni individuo fin dalla nascita di entrare in relazione emotiva con gli altri esseri umani. Il tele si differenzia dall’empatia, la quale e un processo ad una via (una persona è empatica verso un’altra, ma non necessariamente tale atteggiamento viene corrisposto). Potremmo definire il tele come un’empatia a doppia via, ove centrale diventa le reciprocità. A tale riguardo la poesia di Moreno INCONTRO pubblicata in apertura dell’articolo esprime in modo figurato il processo attivato dal tele.
Il tele si differenzia notevolmente dal transfert, processo chiave del trattamento psicoanalitico. Il tele precede storicamente il transfert che del tele è la manifestazione patologica. Potremmo dire che man mano che crescono le relazioni teliche diminuiscono le relazioni transferali, e viceversa un ampio spazio alle relazioni transferali riduce la possibilità di incontro autentico e profondo.
Ancora una volta notiamo come operativamente lo psicodramma punti maggiormente allo sviluppo della capacità telica, rispetto alla elaborazione delle distorsioni transferali.
II.2.4. Teatro terapeutico e catarsi
Fin dai tempi antichi il teatro ha avuto funzioni educative, sociali e terapeutiche per la comunità.
Aristotele nelle sue riflessioni sulla funzione della tragedia sostiene che la stessa “purifica” lo spettatore poiché mobilita la compassione ed il terrore. Il pubblico, partecipando alle vicende dei personaggi del dramma, identificandosi nelle loro valenze paradigmatiche e simboliche (vedi la tragedia di Edipo), ricostruisce la sua identità personale e sviluppa la sua appartenenza alla comunità.
La grande innovazione di Moreno è stata lo spostamento del focus dal pubblico all’attore. Non è più solo lo spettatore che trae beneficiò dalla partecipazione emotiva alle vicende delle DRAMATIS PERSONAE, (catarsi indiretta), ma è soprattutto l’attore in quanto protagonista che, grazie all’azione scenica, può rivivere e ricreare il suo dramma esistenziale, cercando creativamente le soluzioni e gli sviluppi più consoni ai suoi bisogni e desideri (catarsi del protagonista). A tal riguardo è utile richiamare l’aneddoto del giovane Moreno che alla domanda di Freud che gli chiedeva che cosa facesse, rispose: ” cominciò da dove lei finisce Professore. Lei insegna alla gente a capire i suoi sogni, io cerco di dare alle persone il coraggio di sognare ancora ” (Moreno, 1987: 26).
Un’ultima cosa è necessario dire sul concetto di catarsi, per i frequenti fraintendimenti che questo termine produce. Lo psicodramma non è tout-court un “Teatro della catarsi”, anche se il processo di catarsi ha un suo ruolo specifico ed una sua funzione sia in terapia che in formazione.
La catarsi non è la semplice liberazione emotiva di sentimenti né lo scaricamento compensatorio di frustrazioni accumulate nell’ambiente di vita o lavorativo. Per Moreno la catarsi e un processo in due fasi strettamente connesse fra di loro:
? una fase di abreazione emotiva di un affetto o di un contenuto interno rimasto imbavagliato nella vita quotidiana;
? una fase di integrazione di questo nuovo contenuto nel sistema di riferimenti relazionali ed oggettuali della persona.
Da questo punto di vista la catarsi non coincide con l’abreazione, ma diventa un processo integrativo e ristrutturante. E’ più corretto allora parlare di integrazione catartica nello psicodramma più che di catarsi in senso stretto.
PSICODRAMMA E SOCIODRAMMA IN AZIONE
Le considerazioni fatte nei punti precedenti rendono evidente che, per la base filosofica e per il tipo di visione dell’uomo da parte della teoria moreniana, non è corretto parlare di tecniche psicodrammatiche avulse dal loro contesto, ma e più opportuno parlare di modalità psicodrammatiche . Questo non significa che le tecniche psicodrammatiche non possano essere usate al di fuori del loro contesto teorico; significa solo che le potenzialità di queste tecniche si esaltano se il contesto formativo o terapeutico fa riferimento anche ad alcuni aspetti della “filosofia” psicodrammatica.
Cercherò ora brevemente di illustrare alcuni aspetti operativi e tecnici dello psicodramma per rendere più esplicito il particolare setting formativo di cui stiamo parlando.
Azione e riscaldamento
La caratteristica centrale delle modalità psicodrammatiche è sicuramente l’attenzione a tradurre in “AZIONE” quanto rischierebbe di rimanere su un piano di “RACCONTO”, razionalizzazione o intellettualismo.
Azione nello psicodramma non significa però né agire incontrollato né fare senza pensare. Si parla piuttosto di “contesto di azione”, che significa inserire i contenuti emotivi e razionali in un contesto situazionale che renda percepibile plasticamente e comunicabile, mediante un linguaggio diretto, tali contenuti.
Per fare un esempio: è sostanzialmente diverso che un operatore “racconti” il suo rapporto professionale con un utente, oppure che in un contesto psicodrammatico entri nei panni dell’utente, e da quel punto di vista descriva come sente e valuta quell’operatore…
Nel primo caso prevale il racconto e il filtro razionale, nel secondo caso prevale l’azione intesa come confluenza di dati spaziali, situazionali, corporei, razionali ed emotivi.
Il contesto di azione è sempre attivo e solitamente precede il contesto di verbalizzazione, intellettualizzazione e sistematizzazione teorica che viene comunque tenuto presente.
Vi è quindi una spirale continua che parte dal racconto all’azione e dall’azione all’intellettualizzazione per ritornare all’azione, se si rende ancora necessaria…
Direttamente collegato al concetto di azione vi è quello di “ riscaldamento ” (o warming-up). L’azione da un lato è “riscaldamento” o preparazione all’emergenza della spontaneità e della creatività; d’altra parte è necessario in un gruppo creare gradualmente le condizioni (relazionali ed emotive) affinché l’azione possa espletarsi in tutte le sue potenzialità formative e terapeutiche.
E’ per questo che un’attività di riscaldamento precede e crea le condizioni per l’espletarsi dell’attività formativa: infatti vi è un’equazione che vede da un lato spontaneità e riscaldamento e dall’altro ansia e assenza di riscaldamento. Citando Moreno possiamo dire che:
“L’ansia è in funzione della spontaneità.
La spontaneità, secondo la nostra definizione, è la risposta adeguata alla presente situazione. Se la risposta alle circostanze è adeguata, se c’è “pienezza” di spontaneità, l’ansia decresce e scompare.
[…] Partire dall’aspetto negativo, dall’ansia sarebbe un errore dialettico .
Il problema vero sta nell’individuare il fattore dinamico che fa insorgere l’ansia.
L’ansia si manifesta quando fa difetto la spontaneità: non è l’ansia che compare per prima e che comporta a causa della propria comparsa l’attenuazione della spontaneità ”.
(J.L. Moreno, 1980: 185-186).
Direttore
La definizione più corretta del ruolo di conduttore di gruppi terapeutici o formativi con modalità psicodrammatiche è quella di “DIRETTORE”. Contrariamente a quanto potrebbe sembrare a prima vista, è proprio la valorizzazione delle dimensioni di “spontaneità” e “creatività” che richiede un atteggiamento direttivo da parte del conduttore.
Preoccupazione principale del direttore di psicodramma è quella di creare un contesto con alcune regole certe ed alcuni riferimenti spazio-temporali che fungano da contenitore per l’ansia che le situazioni di gruppo o non strutturate potrebbero potenzialmente indurre. Solo se l’ansia viene attenuata, in un contesto di gruppo caldo e contenitivo, è possibile portare a buon fine le potenzialità dei partecipanti e la realizzazione degli obiettivi formativi.
Questo non è un processo magico o mistificante: semplicemente il direttore deve evitare di indurre ansie aggiuntive o situazionali quando esse non sono necessarie. L’atteggiamento di fondo del direttore di psicodramma rimanda al parametro paterno, unendo in sé direttività, empatia, genuino calore umano, unito a capacità d’individuazione.
Se vogliamo usare ancora parametri di tipo familiare, potremmo dire che alle caratteristiche paterne del direttore, nello psicodramma si devono affiancare le caratteristiche “materne” e contenitive del gruppo.
Gruppo
Il gruppo nello psicodramma è concepito in due prospettive:
- la prima come contenitore positivo dei bisogni, desideri ed ansie dei suoi membri;
- la seconda come terreno composito di relazioni teliche (o non teliche) perennemente in movimento ed in evoluzione.
Pertanto si rende continuamente necessario operare a due livelli:
à da un lato costruire un gruppo che nell’insieme “contenga” i suoi membri;
à dall’altro operare, soprattutto con l’ausilio delle tecniche sociometriche, per rendere trasparenti e passibili di modificazione ed evoluzione positiva le relazioni fra i singoli membri del gruppo.
IO ausiliario
L’io ausiliario è una persona del gruppo che riveste in un determinato momento dell’azione psicodrammatica il ruolo di un altro significativo del mondo relazionale (e/o professionale) o del mondo interno del protagonista (= la persona che è in quel momento al centro dell’azione).
Forse un esempio può far capire che cosa è concretamente l’IO ausiliario nello psicodramma. In una situazione di supervisione, un educatore (il protagonista) rappresenta le difficoltà di rapporto con un ragazzo disabile. In questa situazione altri membri del gruppo possono diventare IO ausiliari, entrando nei panni degli altri “significativi”: il ragazzo disabile la madre, il collega, il responsabile della struttura, ma anche personaggi interni quali il padre dell’educatore stesso, la cui presenza interna determina i vissuti e i comportamenti dell’educatore nei confronti del disabile .
L’IO ausiliario può anche rappresentare parti simboliche o fantastiche: ad esempio nel caso di prima può diventare il “senso del dovere dell’educatore”, oppure il senso di “peso sulle spalle” che fisicamente la relazione con il disabile dà all’educatore. L’IO ausiliario ha pertanto la funzione di rendere percepibili e visibili (e pertanto passibili di interazione e di confronto) gli altri reali e fantasmatici che popolano l’esperienza del protagonista.
L’IO ausiliario dal punto di vista del direttore ha la funzione di prolungamento dell’intenzionalità terapeutica o formativa; d’altro canto l’IO ausiliario fa’ da protezione alla trasposizione di attributi transferali sul conduttore. Nello psicodramma infatti il transfert viene agito sugli IO ausiliari e non sul terapeuta o formatore.
II.3.5. Le tre tecniche-chiave dello psicodramma: Doppio, Specchio, Inversione di ruolo
Doppio . Per capire che cosa si intende per doppio nello psicodramma basta pensare a ciò che la madre fa con il neonato quando tenta di intuire e rispondere ai suoi bisogni. La madre è il primo IO ausiliario della storia personale e sociale del bambino: una madre riesce a rispondere ai bisogni del suo bambino se riesce a “doppiarlo”, cioè a dare voce a quanto il bambino sente, desidera, teme ecc…
Il termine doppio rimanda al duplice significato di “doppiaggio cinematografico” (= dare voce a…) e di doppio nel senso di “altro uguale a me che vive accanto a me le stesse mie esperienze” (è frequente nei bambini la creazione del doppio immaginario fantastizzato, che li affianca nelle esperienze di vita). La tecnica del doppio consente in un gruppo di far percepire la universalità del percepire e far esaltare contenuti interni inespressi.
Specchio . Anche in questo caso è utile ricorrere all’immagine della figura materna che, dopo una prima fase nella quale deve soprattutto “doppiare” il bambino, inizia a fargli da specchio, rimandandogli la sua immagine e ristrutturando con dati di realtà la percezione egocentrica del bambino.
La tecnica dello specchio consiste nel riprodurre una scena o una postura del protagonista (ad esempio un atteggiamento perplesso di un educatore di fronte ad un collega) da parte degli Io ausiliari in modo che il protagonista stesso possa vedersi dall’esterno.
Si ha una situazione di specchio e di rispecchiamento nello psicodramma sia quando un membro del gruppo ha la possibilità di vedersi dall’esterno (percependo talvolta aspetti inediti o sconosciuti di sé), sia quando il rimando di realtà degli altri membri del gruppo (“Io ti vedo così…”) favorisce un insight di realtà e di maggiore consapevolezza dell’etero-percezione.
Inversione di ruolo : è la tecnica chiave dello psicodramma. Nello sviluppo psico-affettivo del bambino la capacità di inversione di ruolo (mettersi nei panni degli altri, vedere le cose dal loro punto di vista) segna il passaggio dall’egocentrismo alla capacità di relazione sociale e d’intimità. La tecnica dell’inversione di ruolo consente di allargare la consapevolezza delle proprie relazioni psicosociali ed al tempo stesso favorisce la capacità di individuazione dell’altro: non vi è infatti completa conoscenza di sé senza una almeno parziale uscita da sé, che consente un decentramento percettivo. L’inversione di ruolo è uno strumento potentissimo di ristrutturazione delle relazioni fortemente condizionate da elementi transferali, poiché avvicina alla vera umanità dell’altro, al suo peculiare modo di vedere la vita. Parafrasando il Vangelo Moreno dice: ” Ama il prossimo tuo attraverso l’inversione di ruolo ”
( Moreno, 1984: 158)
Realtà, semi-realtà e plus-realtà
E’ necessario definire questi tre termini poiché nel contesto psicodrammatico essi si alternano e si integrano in fasi successive. Gli spazi di realtà sono quelli nei quali il gruppo e il singolo si confrontano con problemi di realtà, con contenuti intellettuali o con piani di relazione reale (IO operatore X di fronte a te operatore Y). Solitamente si parte in un gruppo di formazione da un piano di realtà, che ricompare altre volte nel corso del lavoro e diventa centrale nella fase conclusiva.
La semi-realtà : è la condizione nella quale il gruppo o l’individuo si trova quando ci si sposta in un piano di gioco “come se”. In questo caso si parla di semi-realtà poiché le situazioni sono fittizie (l’IO ausiliario fa la parte del bambino disabile ma non è il bambino disabile ) ma le emozioni e i vissuti sono veri ed autentici. Quando vengono introdotte le tecniche psico- drammatiche si passa automaticamente ad un piano di semi-realtà.
Plus-realtà : è una “realtà arricchita” dal desiderio o da risorse aggiuntive (Moreno deriva questo concetto da un parallelo col plus-valore di marxiana memoria). E’ utile sia in formazione che in terapia provare a sperimentare come sarebbe o potrebbe essere la realtà se si modificassero alcune condizioni. In tal senso entrare in un piano di plus-realtà significa esplorare il mondo del possibile, del desiderato, del realistico e dell’irrealistico.
Da “Tele. Manuale di psicodramma classico”, Giovanni Boria, Franco Angeli/psicosociologia, 1988
Dott.ssa Flavia Accini
Formatrice, Psicodrammatista, esperta in tecniche di conduzione di gruppo.
Dott. Roberto Cavaliere
Psicologo, Psicoterapeuta
Studio in Milano, Roma, Napoli e Vietri sul Mare (Sa)
per contatti e consulenze private tel.320-8573502 email:cavalierer@iltuopsicologo.it